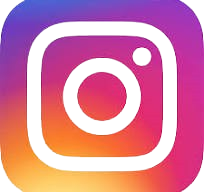L’intervista prende spunto da una ricerca sul tema della umanizzazione della cura, effettuata nel corso degli anni 2021-2022 presso l’Unità Operativa di Riabilitazione Cardiologica dell’Ospedale privato Convenzionato “Villa Serena”; la ricerca ha avuto il supporto e la supervisione della professoressa Pina Lalli che presentiamo con una sintesi del suo ricco e prestigioso curriculum.
Pina Lalli è professore ordinario presso l’Università di Bologna nel settore Sociologia dei processi culturali e comunicativi, vice-direttore del Dipartimento Scienze Politiche e Sociali dello stesso ateneo e membro associato del LERASS-Ceric, Laboratoire d’Etudes et Recherches Appliquées en Sciences Sociales, Université de Toulouse 3 et de Montpellier 3.
Nel 2019 ha fondato il Centro di ricerca CoMediaS (Comunicazione, Media e Spazio pubblico), che attualmente dirige presso il dipartimento, dove coordina anche l’Osservatorio di ricerca sul femminicidio, esito di una ricerca nazionale condotta con colleghi di altre Università. Di recente ha curato per l’editore Il Mulino il volume L’amore non uccide. Femminicidio e discorso pubblico: cronaca, tribunali, politiche; ha pubblicato inoltre numerosi articoli in riviste nazionali e internazionali, su temi di comunicazione sociale e con particolare riguardo alla promozione della salute secondo prospettive sociologiche. In collaborazione anche con Università estere, partecipa a vari progetti di ricerca internazionali.
I numerosi temi emersi nel corso della ricerca prima ricordata, sia dalle riunioni con i professionisti coinvolti nel progetto, sia da interviste con pazienti e familiari sono stati sintetizzati in cinque aree tematiche. Da queste aree, Gianfranco Contini (G.C.) ha preso lo spunto per rivolgere alcune questioni a Pina Lalli (P.L.) che qui ringraziamo, sotto forma di intervista che riportiamo integralmente.
- Prima area tematica: che vuol dire umanizzare in medicina
G.C. Devo ammettere un certo imbarazzo come medico, e come psichiatra. La mia formazione si fonda su una medicina che di per sé è, e vuole essere, necessariamente umana, altrimenti forse avrei studiato veterinaria, ma oggi magari si è più attenti al benessere di un animale, e non me ne vogliano gli animalisti convinti, che all’uomo.
Il problema non credo dipenda dalla estrema tecnicità dell’evoluzione scientifica in ambito medico. Dalle tecnologie di chirurgia robotizzate a distanza per cui il paziente è operato da un computer e da un robot guidato da chirurgie che operano in un altrove virtuale e rischiano di trattare l’essere malato come pura macchina da manipolare, senza saper nulla della persona.
Temo che il problema sia più radicale, estremo e pericoloso. Temo cioè che l’assoluta dominanza dei grandi numeri articolati da algoritmi svincolati dal pensiero umano, stiano condizionando un modo di non-essere dell’uomo che da soggetto persona, diventa oggetto massa che agisce in funzione di stimoli non autodeterminati ma organizzati da automatismi ingegneristici e informatici. In questa ipotesi, forse, anche la medicina dovrebbe ritrovare, ma temo senza riuscirci, la dimensione che la fondava: centrare la cura sulla consapevolezza che ad essere curato è un umano e che chi cura è anch’egli un umano. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensa. Sono forse troppo pessimista? Mi rassicuri, se possibile. Grazie.
P.L. Le tecnologie nuove hanno nel corso della storia sempre sollevato grandi paure e al tempo stesso grandi speranze. In particolare, oggi all’indefinito futuro che possiamo attribuire alle macchine e agli automi si accompagna il rischio di un’ideologia oggettivistica che porta a considerare fondato o reale soltanto ciò che può essere misurato – e rappresentato – con i numeri. Si pensi alla managerializzazione dei processi anche in ambito medico-sanitario: persino quando si parla di qualità si cercano comunque indicatori trasformabili in calcoli statistici quantificabili. La vittoria degli algoritmi credo sia soprattutto una vittoria del potere dei numeri sulle più fragili spalle delle teorie. Una vittoria del «dato» sul processo.
In medicina la cosa in realtà non è nuova e anzi ha segnato le tappe di svolte importanti per le moderne terapie e diagnostiche. I dati epidemiologici e i dati sperimentali hanno guidato la ricerca di farmaci o la verifica dello stato di salute delle popolazioni, permettendo politiche pubbliche importanti per combattere le epidemie, le infezioni, i tumori. Su un altro versante, la riverenza verso i dati quantitativi ha rischiato di monopolizzare le decisioni, come se grazie ad essi si rendesse inutile la riflessione sugli effetti sia clinici sia politico-sociali: cosa comporta considerare l’efficienza delle strutture ospedaliere e delle aziende sanitarie sulla base di costi, percentuali di ricoveri rispetto alla popolazione, tempi delle liste di attesa, numero di parti cesarei per regione, di farmaci dispensati, e così via? Può capitare che si confrontino i diversi sistemi sanitari regionali considerando il numero di residenti e, se va bene, al massimo le fasce d’età, ma non, ad esempio, i diversi stili di vita, le diverse opportunità di accesso al lavoro o le aspettative sociali dei ruoli di genere, i disuguali rischi sul lavoro, i differenti livelli di applicazione delle politiche sociali, ed altro meno misurabile in modo, come si suol dire, «oggettivo». Laddove «oggettivo» = numericamente calcolabile.
Certo, oggi scopriamo anche che i processi di costruzione del dato sono spesso altrettanto importanti, ad esempio perché introducono distorsioni durante la rilevazione e il calcolo, distorsioni non più osservabili quando il dato è ormai definito. In farmacologia si scopre che molte molecole sono state studiate senza tener conto del sesso delle cavie, anzi, sono stati privilegiati i maschi, ipotizzando che il ciclo ormonale riguardasse solo le femmine – in cui le mestruazioni lo rendono visibile – pertanto includerle avrebbe reso più costoso il percorso dell’esperimento. Oppure ci si accorge che non basta dare indicazioni terapeutiche a tutti nello stesso modo, in quanto le persone non sono – sic – semplici organismi dotati di medesime caratteristiche biologiche riducibili a numeri identici sia perché l’organismo di per sé reagisce agli ambienti di vita e relazione in maniera specifica sia perché – doppio sic – le persone possono attribuire significati e pesi diversi alle medesime parole. La medicina personalizzata promessa dall’intelligenza artificiale è certo un’innovazione preziosa e avanzata, ma sembra si basi soprattutto sulle caratteristiche biologico-genetiche: sarà in grado di considerare anche le modalità dinamiche di interazione con gli specifici ambienti e contesti di vita?
Se quindi da un lato gli algoritmi e le procedure robotizzate possono permettere sviluppi importanti, specie considerando le recenti evoluzioni delle cosiddette macchine intelligenti in grado di imparare dagli errori, dall’altro lato è difficile escludere il ruolo dell’interprete umano, fallibile ma per il momento più in grado e più rapido di una macchina nella capacità di intercettare variazioni contestuali e contingenti: ad esempio, situazioni fuori dall’ordinario standard, o rischi di distorsione nell’applicazione algoritmica in quel determinato caso. Il modello matematico può essere utilizzato per calcolare in fretta e orientare la decisione; l’essere umano deve – e può – assumerne la responsabilità. Per il momento, l’ipotesi di delegare interamente la responsabilità di decisione alle macchine resta, mi parrebbe, un mito.
- Seconda area tematica: la medicina è stata nel suo evolversi anche “disumana”?
G.C. Come altra questione in fondo collegata alla precedente, vorrei porre una riflessione su quanto emerso dall’analisi della letteratura più recente nell’ambito della umanizzazione delle cure. È condiviso da molti che umanizzare sia soprattutto avvicinare il paziente nella sua condizione di malato all’idea di poter vivere durante la sua malattia in una condizione “umana” e non come oggetto portatore di sintomi da diagnosticare e curare. Ma in fondo non mi pare che ci sia molto di nuovo dai tempi di Euripilo e Patroclo, quando Euripilo, nel curare la ferita di Patroclo provocata dalla freccia, non si limita a lenire il dolore fisico, ma dedica attenzione e tempo a rassicurare e sostenere l’angoscia e la paura del paziente.
P.L. Accettare e, nel contempo, sfidare la finitudine umana – di cui la malattia è uno dei segnali rilevanti – ha nel corso della storia attraversato tappe spesso crudeli. Dall’eliminazione dei deboli dalla rupe Tarpea di spartana memoria al quesito sofferto su quale criterio di priorità di terapia intensiva seguire in uno scenario di risorse scarse come è accaduto durante la recente pandemia, il trattamento che le varie società hanno messo a disposizione è lastricato, potremmo dire, di alterne vicende fatte di vittorie e sconfitte per la dignità dell’essere umano. L’anelito, tuttavia, di salvaguardare la persona non si è mai sopito: come Patroclo, in pieno combattimento, trova comunque il modo, il coraggio e il tempo di lenire la ferita di Euripilo, ancor oggi, nonostante la battaglia contro il tempo e l’incombere dell’efficienza ad ogni costo, credo sia in fondo difficile per un medico o un infermiere evitare l’incontro con la «persona» che soffre. La sofferenza può farsi portatrice di sensibilità umana, quasi una mimesi spontanea che travalica i ruoli e sia pure per un attimo avverte o perfino riconosce gli indizi della comune identità. Paradossalmente, proprio questa «umanità» permette di individuare le soluzioni e la performance da raggiungere, giocando a rimpiattino con la presa di distanza professionale necessaria. In altre parole, la consapevolezza della presenza umana dell’altro come persona, lungi dal distrarre dai compiti razionali della cura, può invece potenziare la nostra capacità di cura. A meno di non considerare la propria azione di cura mero intervento tecnologico, che nulla ha più a che fare con l’arte dell’interpretazione e dunque col saper essere oltre che saper fare.
- Terza area tematica: le ricerche sulla umanizzazione delle cure seguono diverse metodologie, si può individuare la metodologia migliore o si tratta di processi in divenire che richiedono approcci differenti?
G.C. La tendenza di alcuni orientamenti specialistici, soprattutto in campo oncologico, è quella di proporre “manifesti” che tracciano il percorso per raggiungere l’umanizzazione delle cure. Prendendo spunto da quello sviluppato dagli oncologi possiamo evidenziare i seguenti punti:
- il progresso nelle terapie e nelle conoscenze scientifiche;
- il diritto alla salute e la sostenibilità delle terapie;
- l’umanizzazione vera e propria mediante:
l’applicazione del modello clinico bio-psico-sociale,
b. la comunicazione efficace medico-paziente,
c. il patient empowerment, - la valutazione partecipata dell’umanizzazione anche grazie al coinvolgimento del volontariato
Il documento è il frutto di un think tank multidisciplinare, promosso da Merck, che ha visto riuniti i principali interlocutori nell’ambito dell’assistenza oncologica in Italia.
Tra le dichiarazioni del manifesto e la traduzione operativa che possa renderlo praticamente utilizzabile quali strategie si possono adottare? La ricerca realizzata presso l’U.O. di riabilitazione cardiologica della Casa di Cura Villa Serena può rappresentare un esempio?
P.L. Le dichiarazioni di principio contenute nei «manifesti» costituiscono pietre miliari importanti per dare visibilità e continuità in una determinata comunità, in questo caso scientifica, agli aspetti che occorre prendere in considerazione in modo condiviso. Sono in qualche modo le regole grammaticali che occorre darsi per orientare in modo corretto le proprie azioni. Ma proprio perché generali richiedono, come bene ha fatto la ricerca realizzata nella Casa di Cura Villa Serena, una più precisa contestualizzazione che sappia tradurre in pratiche specifiche ciò che più si ritiene adeguato sul piano operativo dei singoli e delle situazioni. Non solo: l’osservazione e l’esercizio di auto-osservazione realizzati permettono di far propri i principi condivisi andando oltre la mera dichiarazione perché se ne rilevano le opportunità effettive come anche gli ostacoli da superare nel tempo per renderli efficaci. In altre parole, li si trasforma in regole che quella specifica comunità di pratiche cala nella sua realtà quotidiana negoziando i margini o i limiti che si possono reputare accettabili all’interno sia del quadro di principio generale sia della propria concreta cornice organizzativa, tenuto conto delle risorse effettive e di quelle realisticamente acquisibili. Inoltre, la dimensione partecipativa della metodologia adottata, facendo esprimere in prima persona gli operatori e i professionisti coinvolti, fa sì che la petizione di principio generale non si affermi come un inverosimile diktat top-down, ma si lasci assimilare nel confronto con le competenze pratiche di chi lavora sul campo: a loro si chiede di elaborare in forma bottom-up grammatiche di comportamento conformi alle linee guida del manifesto ma idonee e appropriate per il proprio contesto.
- Quarte area tematica: ricerca qualitativa e ricerca quantitativa. Contrapposizione o integrazione?
G.C. La ricerca qualitativa in campo sociologico può dare un contributo agli studi medici sulla umanizzazione? E se la risposta risultasse affermativa, come si può giustificare tale approccio sul piano scientifico? Domanda credo lecita in un’epoca ormai dominata dai grandi numeri e dalle scelte, non solo politiche ma anche economiche, che sembrano basarsi solo su predeterminati algoritmi?
In altri termini c’è un futuro per la ricerca qualitativa? O, come nei movimenti legati alla cosiddetta decrescita, siamo in un settore in declino definitivo, sconfitto dalle politiche che privilegiano pochi “eletti” vincenti?
P.L. Da quanto prima accennavo discende in effetti quel che oggi chiamiamo «umanizzazione delle cure»: indispensabile non solo o non tanto perché occorre uno sguardo benevolo e comprensivo all’essere umano prim’ancora che al paziente come oggetto di cura, ma soprattutto perché altrimenti le cure possono diventare inefficaci. Se non mettiamo ogni volta al centro la persona col suo portato di relazioni, con tutto il carico di indeterminazione e incertezza che essa comporta rispetto al mito tecnocratico della standardizzazione dei protocolli, qualunque tecnologia, anche la più raffinata, rischia di fallire. Così come l’aereo ultrasonico non ha sostituito il piacere e l’utilità di una passeggiata a piedi (e anzi oggi solleva dubbi circa il suo impatto ambientale), ma comunque ci permette di viaggiare con maggiore facilità per raggiungere i nostri cari o partecipare ad una riunione d’affari in Australia, così – riterrei – nessuna tecnologia algoritmica o robotica può sostituire del tutto l’efficacia terapeutica della relazione umana, interpersonale, medico-paziente.
Come ci indica fra gli altri l’antropologo Claude Lévi-Strauss, l’efficacia simbolica delle parole dello stregone guaritore aborigeno non è semplice indizio di pensiero primitivo o magia, ma il segnale importante della possibilità umana di dare un senso alle cose, specie di fronte all’incombere di una malattia. Gli indizi di efficacia simbolica sono forse oggi molto diversi da quelli, per lo più ammantati di mistero e segreto, che un tempo caratterizzavano il lavoro dello sciamano.
Il percorso di guarigione è certamente favorito e reso più efficace dalle caratteristiche tecnologiche di diagnosi e terapia oggi più avanzate e fondate di ieri, e verso le quali da un lato ci si attende venerazione cieca ma dall’altro si diffida. Proprio per questa ambivalenza, e per la rivendicazione di un sapere basato sull’evidence più che sulla formula magica, ci viene richiesto di prestare attenzione ai fattori umani e relazionali che rendono ogni caso specifico.
Ciò richiede metodologie qualitative: l’ascolto, l’individuazione e l’interpretazione adeguata delle sfaccettature che un medesimo sintomo può assumere in un determinato contesto e ambiente di vita per i diversi soggetti che lo abitano e per i quali differenti possono essere, oltre che le opportunità di accesso, i pesi e le «misure» attribuibili ai singoli segni e implicazioni che indicano il confine – simbolico e non soltanto biologico – tra salute-benessere e malattia-malessere. Prendiamo ad esempio l’apparente scontata formula dei cosiddetti stili di vita «sani»: basta elencarli a tutti in modo indifferente, o si possono incontrare significati di peso diverso di questo o quell’aspetto in situazioni personali in cui prevalgono esigenze differenti?
Occorre dunque favorire una direi ovvia seppur dinamica integrazione tra qualitativo e quantitativo, che non vanno contrapposti perché si completano a vicenda: diventare sempre più abili nel configurarli in modo integrato permette di pervenire ad una decisione di cui assumere responsabilità proprio perché consapevole di aver esercitato utili domande riflessive e creazione-lettura di dati rilevanti.
- Quinta area tematica: medicina empatica e medicina difensiva sono in contrapposizione insanabile?
G.C. La ricerca ha evidenziato una buona propensione dei professionisti verso i pazienti, ma il tema dell’empatia, della competenza nella comunicazione, nella estrema variabilità dei comportamenti dei pazienti e dei familiari, delle sempre più pervasiva medicina difensiva, delle informazioni che circolano sul web, hanno resa più complessa la professione sanitaria. Come fare? Può la formazione continua essere uno strumento valido? E che tipo di formazione potrebbe rivelarsi utile?
P.L. La fiducia medico-paziente penso sia una delle poste in gioco più importanti. Certo, è una posta in gioco difficile, specie quando il paternalismo o anche l’autorevolezza del medico possono essere più facilmente messe in discussione da un paziente che si informa anche altrove o che abbia la sensazione di essere trattato come un numero tra i tanti. Inoltre, la prevalenza – com’è consuetudine per la routine stessa dei media – di cattive notizie sulla cosiddetta malasanità non fornisce un quadro di riferimento favorevole. Eppure, la fiducia resta cruciale: reciproca, oserei dire. Un medico che ostenti superiorità da dare per scontata di fronte ad un paziente che sarebbe tenuto a non saper nulla di diagnosi e terapia perché dovrebbe solo affidarsi alle sue sapienti mani non sempre è probabile ottenga maggiore fiducia di chi, invece, manifesti interesse a ciò che il paziente sa o crede di sapere sui suoi sintomi e sulla loro cura.
La fiducia non è un oggetto da dare per scontato, perché va costruita, nel tempo e col tempo: quel che spesso manca è appunto il tempo, anche solo per capire se c’è un fraintendimento o un cenno di domanda che resta inespressa. Cercare informazioni sul web o parlare con altri o persino contestare una parola utilizzata non implicano necessariamente mancanza di fiducia: spesso sono anzi indizi di relazione, segnali dell’intenzione di capire meglio per fare meglio, per una compliance più consapevole. Aver paura di quello che va sotto il nome di empowerment – nel senso di far proprio quel che non attiene direttamente al sapere pregresso – ostacola il percorso della cura e anzi apre la strada a quello che a mio parere è il pericolo maggiore per il cittadino, oltre che per il professionista della sanità: la medicina detta difensiva, quella che si attiene strettamente al protocollo pur di stare dalla parte della ragione formale o dell’esito giuridico.
Se empatia indica – alla lettera – capacità di saper riconoscere le caratteristiche e le aspettative dell’altro nel contesto specifico della relazione, essa è certamente la base indispensabile per intessere un legame di fiducia: per quanto possa essere più o meno stabile, è l’unica opportunità per comprendere e far comprendere. L’auto-osservazione, lo scambio di esperienze fra sanitari, la capacità di imparare anche dai propri errori, l’esercizio costante di ascolto delle reciproche aspettative di ruolo in situazioni differenti che insegnano a ricordare che ci sono disuguaglianze, determinanti sociali diversi, possono essere elementi utili per una formazione che potremmo persino considerare continua o permanente quando si fa, come il medico, un servizio «alla persona».
Si conclude qui il breve, ma crediamo intenso e stimolante incontro con Pina Lalli che ancora una volta ringraziamo per la disponibilità e la competenza. Gli argomenti trattati sono complessi e meritevoli di molti approfondimenti. Ci sembra comunque degno di essere rimarcato il contesto nel quale la ricerca si è svolta: quello di una struttura privata, che grazie alla visione della direzione aziendale e all’impegno dei professionisti, pone l’accento costante sulla qualità delle cure e sull’attenzione al paziente, preoccupandosi di mantenere un elevato livello tecnologico insieme alla qualità della relazione empatica necessaria per la cura migliore.
A cura di Gianfranco Contini